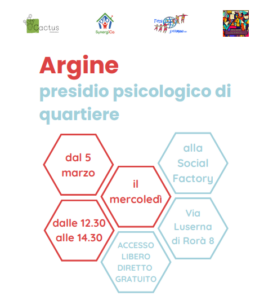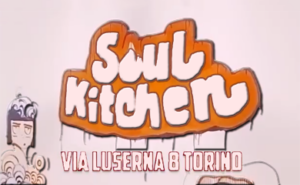Nuove comunità – Nuove sfide per i giovani e per l’ambiente
Terza Settimana è luogo di nuova progettualità che concentra la propria attenzione sulle nuove sfide del welfare. Quello che dovrà pensare alle esigenze delle nuove comunità, con particolare attenzione ai giovani e all’ambiente.
Il nostro intento è contribuire a creare rigenerazione sociale delle nostre comunità. Siamo partiti da processi di riuso che ha trasformato spazi svuotati in luoghi che alimentano nuove forme di vita e di economia comune. Per questo abbiamo scelto di insediare le nostre attività in luoghi popolari come la residenza edilizia Residenziale Pubblica o luoghi occupati nel passato daattività mafiose. Siamo così passati da luoghi fisici a luoghi di relazioni sociali orientati alla concreta solidarietà.
Dalla gente per la gente: un fenomeno circolare
Il Social Market è una realtà di acquisto collettivo dove le famiglie sono inviate da Enti che sostengono la loro situazione di difficoltà socio economica.
Qui le persone possono fare una spesa mantenendo sostanzialmente una linea di dignità nella spesa stessa, perché possono insieme i nostri volontari comporre la loro spesa secondo diciamo le loro loro preferenze in modo tale da mantenere in qualche misura una certa continuità con quando avevano un reddito.
La solidarietà circolare

Sono stanco di veder utilizzare il termine “crisi” solo come sinonimo di “disperazione”. Anche durante la crisi nascono i bambini, ci sono ragazzi che studiano, scoperte che si affermano e cambiano le cose, insomma anche in un periodo come questo nasce il futuro, perciò non dobbiamo crogiolarci in una prospettiva di disperazione, semmai attrezzarci a ricavarne utili indicazioni e spunti per uscirne indenni e rafforzati. Credo, per questo, che giornate di riflessione come quella proposta dalla Caritas svolgano l’importante compito di rilanciare l’urlo della speranza..
Ci troviamo oggi ad affrontare le nuove povertà, quelle che hanno reso vulnerabili anche le famiglie che vivevano una condizione socio economica stabile e che poi, a causa della crisi economica in atto, hanno perso le loro sicurezze. Qualche giorno addietro mi trovavo in uno dei Social Market di Terza Settimana e mi sono imbattuto in una scena paradigmatica che mi aiuterà a spiegare meglio il mio pensiero sul cambiamento di mentalità necessario da perseguire nel campo della solidarietà, soprattutto di fronte alle nuove povertà. Una signora entra nel market come beneficiaria del servizio per problemi economici e, dopo essersi presentata, si appresta a fare la spesa. Dall’altra parte del bancone a servirla c’erano una studentessa di 25 anni universitaria (tra una spesa e l’altra studiava latino per un esame), un pensionato ed una signora, anche lei beneficiaria del progetto, che si trovava in quel momento a svolgere il suo turno di volontariato. La stessa persona che è entrata a fare la sua spesa, la settimana precedente si trovava anche lei dietro al bancone a donare il suo tempo per altri che vivono le sue stesse condizioni. Da questa circolarità credo sia importante avviare una seria riflessione sulle “novità” in termini di un disegno di solidarietà che sa guardare al futuro. I campi su cui lavorare sono almeno due.

Il primo individua come priorità il bisogno urgente di cambiare la ratio che guida la nostra azione di volontari: bisogna sforzarsi di ‘lavorare con gli altri’ e non riduttivamente ‘lavorare per gli altri’. Solo all’affermarsi di questa nuova mentalità, l’individuo, invece di pensarsi solo come “assistito”, maturerà come “persona” impegnandosi così nell’esercizio di una proficua e matura cittadinanza a tutto tondo. Mi ha colpito la frase di ringraziamento di una signora beneficiaria dei nostri servizi. Ci diceva che, chiedendole di fare volontariato, la costringevamo ad uscire di casa e sentire che ancora qualcosa può fare, sfuggendo così alla depressione che sempre più si impadroniva di lei, accentuata dalla difficoltà di trovare lavoro. Contrapponendosi alla spinta individualistica, oggi dominante nella nostra cultura, il nostro ruolo di volontari non può sottrarsi da una profonda funzione educativa, tesa a creare le condizioni di una costruzione della propria identità, sociale e individuale, attraverso la relazione con l’altro. E questo è reciproco, vale sia per chi ha scelto di fare il volontario sia per chi si trova nella condizione di assistito. Molte volte ci capita che le persone, che da beneficiari diventano volontari, ci ringrazino perché il loro tempo a disposizione (purtroppo molto per l’assenza di lavoro) assume un significato di riconoscimento di dignità e accrescimento dell’autostima.
Quindi, se l’identità classica del volontariato sta nel saper donare gratuitamente, oggi il risultato del proprio gesto generoso va valutato nella capacità di generare reciprocità. Altrimenti il nostro impegno si riduce ad un alveo di autoreferenzialità, generosa ma ripiegata su noi stessi. Potremmo quasi dire che non è propriamente volontaria l’azione di chi non consente al beneficiario di porre in essere una esperienza di restituzione. Un’ autentica azione di volontariato genera reciprocità e quindi libera colui che è il destinatario dell’azione volontaria da quella “vergogna” di cui già parlava Seneca nella X Lettera a Lucilio. Insomma è ora di capire quanto i portatori di bisogni siano anche portatori di conoscenze e di risorse.
La seconda direttrice è quella del rapporto tra volontariato ed Istituzioni. La costruzione di una nuova comunità non può prescindere dal lavoro che spetta alle Istituzioni. Di fronte a questo universo variegato e “liquido”, i tradizionali strumenti di assistenza paiono non del tutto adeguati. Mentre il volontariato, per sua natura, è più flessibile e pare adattarsi meglio ai cambiamenti, per l’ Istituzione questo nuovo quadro impone una riflessione profonda sul proprio ruolo e sul modo di erogare gli aiuti. La crisi finanziaria dello Stato e l’allargamento della forbice tra risorse disponibili e ampliamento della gamma dei bisogni hanno reso evidente a tutti la crisi interna degli interventi tradizionali. Ebbene, è in questo quadro che si spiega la ripresa di interesse verso il modello civile di welfare, un modello che affonda le sue radici nell’economia civile di mercato e che vede le organizzazioni della società civile giocare un ruolo importante.
Nello stesso tempo è necessario che il volontariato rivesta un ruolo da “maggiorenne” nei confronti delle Istituzioni e si sottragga dal troppo spesso attuato tentativo di essere utilizzato come azione supplente del pubblico, che attraversa oggettive difficoltà nel garantire ai cittadini risposte necessarie alle esigenze e ai bisogni. Il volontariato, pur condividendo la responsabilità sociale, non deve ridursi a “longa manus” del pubblico: è necessario che diventi un laboratorio per le nuove risposte che nascono dal “saper ascoltare” le persone.
In questo senso le esperienze di volontariato si possono definire innovative perché vanno ad occupare spazi non presidiati e forniscono una soluzione “chiavi in mano” alle nuove istanze di aiuto interpretabili ed intercettabili con difficoltà dalle Istituzioni.
Mentre nel passato i servizi sociali erano impegnati a sostenere le persone che erano in attesa di rientrare nel mercato del lavoro, oggi fanno i conti con chi spesso non ha più prospettive in quel senso, almeno a breve termine. Con chi appare più un “tagliato fuori” piuttosto che una persona in attesa. I volontari dei centri d’ascolto ne hanno la piena percezione e sanno che da soli non potranno far fronte alla massa di persone “incollocabili”. Una situazione nuova a cui nessuno é preparato fino in fondo e che richiede una profonda revisione della capacità di risposta; si tratta di coinvolgere paritariamente i soggetti principali in quella che si definisce “sussidiarietà circolare”: enti pubblici, no profit e imprese profit.
Le Istituzioni devono riscoprire il proprio ruolo originario accanto alle persone. Oggi troppo prevalgono i “regolamenti” sulle persone, impedendo spesso quegli interventi utili che, in molti casi, potrebbero ridurre i costi della macchina e aumentare i benefici ai destinatari. Inoltre, la collaborazione sempre più stretta con il volontariato, che più naturalmente ascolta in profondità chi vive in una quotidiana e persistente ansia, angoscia per il futuro proprio e dei propri figli, dovrebbe permettere di elaborare insieme (pubblico e privato) risposte adeguate e rapide alla nuova condizione di vulnerabilità di ampie fasce della popolazione.
Insomma, sono convinto quella speranza che richiamavo in apertura si può ancora accendere se sappiamo oggi sfidare la crisi trasformandola in creatività responsabile ad ogni livello sociale. Riusciremo così a riprogettare una comunità che sembra oggi avere perso il senso del proprio destino.
Bruno Ferragatta
Articolo apparso su Voce del Popolo il 29/03/2014